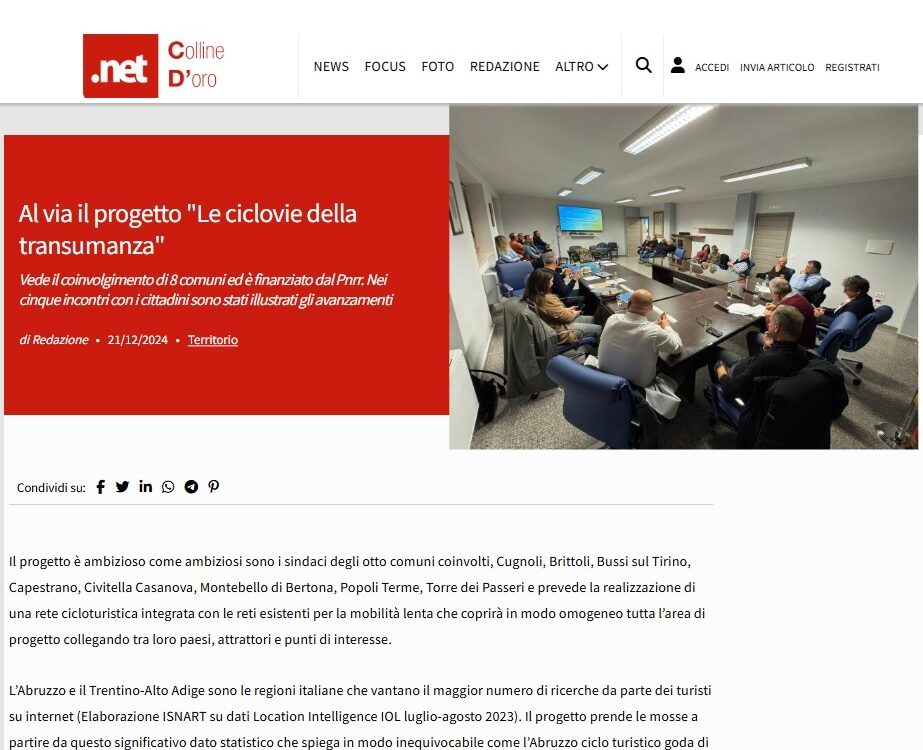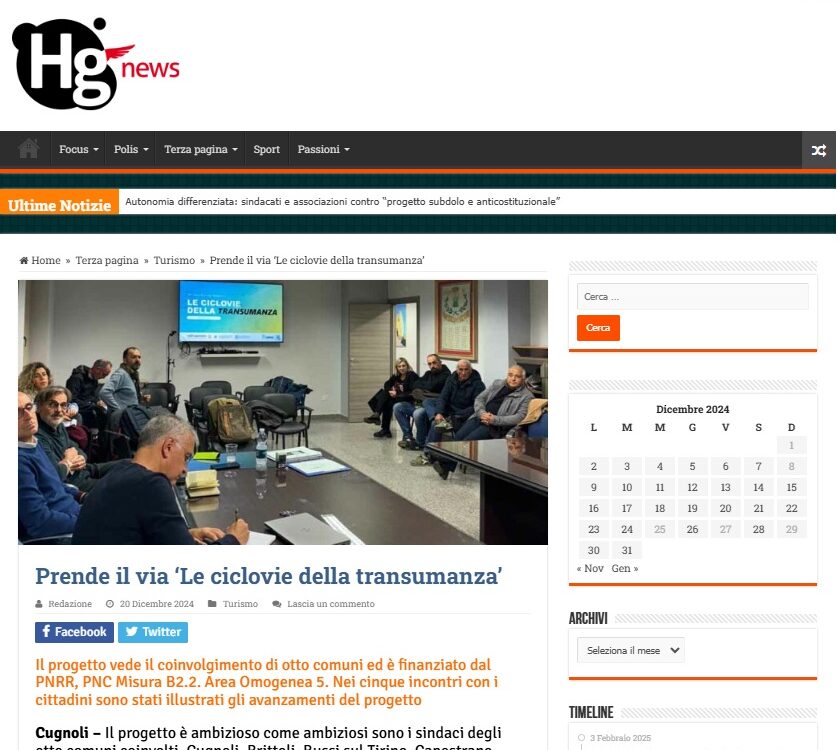Il vocabolario della lingua italiana Treccani ci dice che Restanza è singolare, femminile. E continua così «1. In senso proprio e figurato, ciò che resta e permane; anche, ciò che avanza o non si consuma. 2. Negli studi antropologici, con particolare riferimento alla condizione problematica del Sud d’Italia, la posizione di chi decide di restare, rinunciando a recidere il legame con la propria terra e comunità d’origine non per rassegnazione, ma con un atteggiamento propositivo […] Sia nell’accezione di ‘ciò che resta, avanza’ che in quella, generica, di ‘soggiorno in un luogo’, la parola ha isolate attestazioni trecentesche».
Il quotidiano d’Abruzzo Il Centro, a partire dal suo direttore, ha sposato la causa e, per certi versi, ha determinato la fortuna di questo termine in Abruzzo, a partire dall’inizio del 2025. Restanza non è più solo una parola, ma un progetto politico.



Una serie di articoli pubblicati in questi primi due mesi dell’anno, ci informano della restanza letteraria, della restanza legata alla nascita di nuovi bimbi, della restanza dei paesi. In sequenza, uno dopo l’altro. Perché? E, soprattutto, cosa vogliono trasmettere?
È il rilancio del grande tema delle aree interne, dell’Appennino, e dunque dell’Abruzzo. Ovvero una campana che suona per tutti e che richiede impegno per proporre progetti, cercare nuove strade per contribuire a rallentare lo spopolamento che interessa questi territori e che, in prospettiva, possa portare a un’inversione di tendenza caratterizzata da processi di neo-popolamento.
Le cause dello spopolamento sono molteplici e sfuggono a definizioni o incasellamenti univoci, ma se proprio dovessimo individuare una causa scatenante, certamente andrebbe individuata nella mancanza di lavoro.
Ogni politica attiva nel senso del neo-popolamento dovrebbe partire da questo punto: creazione di posti di lavoro stabili e competitivi con il canto delle sirene che proviene dalle grandi città perché non bisogna dimenticare che il processo di inurbamento, la voglia di città che è nella maggior parte della popolazione, è un processo globale che interessa tutte le aree del mondo e dunque anche l’Appennino e l’Abruzzo. La città, l’area urbana, attrae per tante ragioni e la più importante è molto semplice e si può sintetizzare così: la città offre le risposte che cerchiamo alle nostre domande.
Per competere ci si deve relazionare con le persone su questo stesso canale: offrire risposte alle domande. Quante più risposte si è in grado di offrire più si è competitivi.


I numeri ci dicono che l’Appennino e l’Abruzzo perdono, ogni anno, un numero crescente di giovani che scelgono altri luoghi per vivere e costruire le proprie vite, perché altri luoghi offrono più possibilità di emancipazione sociale e culturale. La sfida la si affronta su questo stesso terreno, senza infingimenti e senza retorica se si vuol provare a dare contributi concreti a questa, nobile, causa.
Non molti anni fa, un altro termine occupo il centro del dibattito culturale nel nostro Paese: resilienza.
Un termine fino ad allora poco o per niente utilizzato e che faceva riferimento alla tecnologia dei materiali, (capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi) ma che in psicologia assume questo significato: la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.
Il termine balzò all’onore delle cronache dopo il drammatico terremoto di cui fu vittima L’Aquila nel 2009 e che causò 309 vittime, più di 1600 feriti e oltre 10 miliardi di euro di danni.
A partire dalla reazione del popolo aquilano e abruzzese in generale e per un periodo piuttosto lungo si parlò spesso di resilienza, della capacità di un’intera comunità di resistere agli eventi, di ribellarsi alla sorte avversa.
Il successo del termine, ma più in generale di quel concetto, toccò il suo punto più alto con il film di Riccardo Milani, Un mondo a parte, che aveva come protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Protagonista la piccola comunità di un paese dell’Appennino abruzzese che si ribella e con essa l’insegnante, alla chiusura dell’unica scuola del paese. Il film, che ha avuto un successo clamoroso e per certi versi inaspettato, ha sancito la fine della fortuna del termine resilienza e aperto le porte a restanza. Preso atto che questa comunità è stata e continua ad essere resiliente, si passa ad una fase successiva, di progetto e di prospettiva, ed è qui che entra in gioco la restanza «la posizione di chi decide di restare, rinunciando a recidere il legame con la propria terra e comunità d’origine non per rassegnazione, ma con un atteggiamento propositivo».